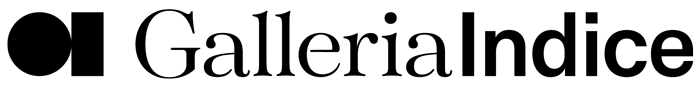Testo critico a cura di Mauro Zanchi
«Questi nostri attori erano spiriti, e tutti si sono dissolti nell’aria, nell’aria sottile come loro. […] E come questo spettacolo senza realtà che ora è svanito, tutto il mondo scomparirà nel nulla senza lasciare dietro di sé neppure il vapore di una nube. Noi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni; e la nostra breve vita è cinta di sonno» (William Shakespeare, La Tempesta, 1610-1611).
Le parole pronunciate da Prospero nel quarto atto de La Tempesta risuonano come un monito misterioso. E pensare che precedentemente innumerevoli momenti teatrali avevano animato la storia con scene che parevano più vere del vero, pervase dalla magia naturale. Ora proviamo un salto reale per raggiungere ciò che ci riguarda in prima persona, tra le parole che qui lo evocano (il salto) e la realtà che ci contiene. La rappresentazione della nostra vita – giorno dopo giorno, nella scansione temporale degli attimi – si sovrappone e si identifica con un’altra rappresentazione, che noi sentiamo vicina e che non riusciamo a comprendere in profondità, nella sua vera sostanza. Una parte di questa realtà è onirica: costruisce trame e dipana significati attraverso immagini e simboli interiori. Queste energie psichiche muovono anche l’insostanziale presenza di qualcosa che non è conscio, liberano messaggi, da interpretare prima che svaniscano o vadano a depositarsi negli spazi delle dimenticanze o che si mischino alle contingenze pratiche della vita quotidiana. Immaginiamo Ariel, lo spirito al servizio del mago Prospero, come qualcosa che sia in grado di rendere visibili – di tradurre in immagini – le storie e i bagliori elettrici notturni che vengono prodotti dal nostro cervello mentre dormiamo. Lo spirito naturale è in attesa di essere liberato dal mago che l’ha evocato per portare a compimento lo spettacolo che ha preso corpo nella sua immaginazione. Nel frattempo, lo spirito incalza l’artista per il compimento della sua opera, un compimento che non sarà un risultato consolatorio, bensì un’amara riflessione sul destino di ogni singola persona. In questa riflessione prende corpo anche qualcos’altro: nella materializzazione dell’effimero cerchiamo uno strumento o un linguaggio in grado di percepire in modo più chiaro ciò che ha percorso la nostra mente o che ha innescato un’intuizione. Ogni artista si affida a un medium per visualizzare fisicamente una singola immagine o il flusso delle figurazioni interiori. In questo momento storico in cui non è stato ancora inventato uno strumento tecnologico in grado di tradurre visivamente le trame e i messaggi dei sogni ci si affida a qualcos’altro che ne evochi la consistenza, sia materiale sia intellettuale. Attraverso il progetto urtümliches Bild (nome con cui Carl Gustav Jung chiama gli archetipi, intesi come immagini primordiali collettive contenute nei sogni), Silvia Bigi ha invocato i demoni degli attuali algoritmi, come Prospero ha condotto a sé la presenza di Ariel, per vedere in cosa consista il tentativo di processare la materia dei sogni notturni attraverso un’intelligenza artificiale. I racconti di alcuni sognatori sono stati portati dalle ali degli algoritmi verso una visualizzazione illogica. In realtà, gli algoritmi attuali sono fondati su paradigmi pseudoscientifici. Secondo Flavia Dzodan sono “una forma di esoterismo, non diversa dalla cartomanzia, dall’astrologia e da presagi dedotti da geometrie sacre”[1]. Matteo Pasquinelli ci informa che in informatica l’algoritmo è un diagramma astratto che emerge dalla ripetizione di un processo, è un’organizzazione di tempo, spazio, lavoro e operazioni, e indica un insieme di istruzioni, che deve essere applicato per eseguire un’elaborazione o risolvere un problema: “È una procedura computazionale che recepisce un valore in ingresso (input) e restituisce un valore in uscita (output). La visione della macchina è cibernetica, derivando dall’accumulo di dati che immagazzina, memorizza, archivia e rielabora”[2]. È interessante questa deriva di matrice esoterica legata al senso tecnologico dell’algoritmo, che è utilizzato per risolvere un problema, nel nostro caso la visualizzazione di impulsi effimeri e di racconti verbali onirici. Mi interessa qui considerare gli algoritmi utilizzati da Silvia Bigi come una produzione di soluzioni in divenire, e vedere le immagini derivate come una deriva anche ontologica, avendo ben presente che l’algoritmo non è mai neutro e assorbe le direttive di chi gli ha dato una struttura. La sua logica formale sostanzia la visione computazionale, negozia e rinegozia sensi con la realtà e con le complesse e ambigue informazioni che arrivano dal reale.
Sono affiorate così immagini al contempo surreali, astratte, prive di regole prospettiche, derivate da intra-azioni fra gli inconsci umani (soggettivi?) e quelli tecnologici (oggettivi?). Cosa ci figuriamo veramente quando nominiamo la parola “archetipi”? Esistono immagini originarie, già presenti nel nostro DNA prima che si faccia esperienza diretta del mondo in cui viviamo? Silvia Bigi si chiede: “E se un giorno smettessimo di sognare? Le immagini-archetipo prodotte dalle macchine andrebbero a comporre quella che potremmo chiamare un’archeologia della memoria umana?”
Una domanda simile se la pone probabilmente anche Claire Tourneur – personaggio del film Fino alla fine del mondo (1991) diretto da Wim Wenders -, ossessionata dal desiderio di visionare i propri sogni registrati dalla macchina su supporto digitale. Claire cerca di comprendere se stessa e i messaggi del suo inconscio affidandosi alle immagini restituite dal prototipo fantascientifico che registra e traduce gli impulsi cerebrali, in modo da poterli trasmettere come pensieri innestati anche nel cervello dei non vedenti. Il regista tedesco, però, nella chiosa del film lascia che sia il potere taumaturgico della parola e del racconto a fare in modo che Claire si liberi dalla sua compulsione legata alle immagini. Alla luce di tutti gli spostamenti “sostanziali” affidati alle parole che ci hanno condotto fin qui, nel rapporto tra il linguaggio verbale e quello delle immagini in questione, ora ri-osservo la serie urtümliches Bild e immagino che siano manifestazioni del pullulare di effimeri quanti di spazio e di materia, possibilità e incontri (casuali o meno) di spazio e particelle elementari. Particelle e quanti che sono della stessa sostanza di cui sono costituiti i nostri sogni, emozioni, proiezioni immaginali, nella nostra “breve vita cinta di sonni”. Questa notte ci appariranno le latenze delle immagini che sogneremo. Forse riconosceremo alcuni frammenti o forme astratte che sono stati colti nella serie urtümliches Bild oppure vedremo altre immagini che sono pronte per accaderci nell’interiorità.
[1] Flavia Dzodan,“Algorithms as Cartomancy”, in Schemas of Uncertainty, a cura di Danae Io e Callum Copley, Amsterdam 2019, pp. 19-47.
[2] Si veda: https://www.e-flux.com/journal/101/273221/three-thousand-years-of-algorithmic-rituals-the-emergence-of-ai-from-the-computation-of-space/